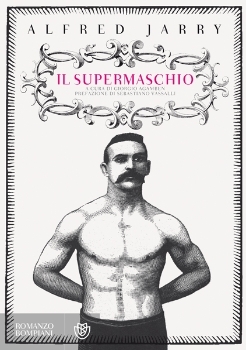È il 14 luglio del 1992. Da lì principia la serie di fotografie del volume Tom Waits di Guido Harari, da poco uscito per Tea. Il noto fotografo definisce “melodia cinetica fatta di piccoli scatti” il movimento instancabile dei muscoli facciali e delle braccia del grande musicista americano quando ha la fortuna di incontrarlo nella bellissima Place des Vosges di Parigi per la promozione dell’album Bone Machine. Un uomo la cui pelle sembra fatta di una gomma dura ed elastica insieme, in grado di fargli assumere sembianze e maschere diverse di uno stigma originario che è quello di un vero genio. Se “il viso gli si gonfia e deforma” spiazzando il fotografo, e se la sessione di scatti troverà la sua cifra soltanto nel gesto improvvisato di Waits che afferra un telo scuro pensato come fondale e trasformato in un gigantesco mantello dentro e sotto il quale svolazzare come uno strambo animale, così il giornalista Burt Bull nel novembre del ’77 (Waits comincia a farsi un nome importante) non sa bene che pesci prendere nel suo goffo tentativo di imbastire un’intervista decente col musicista seccato di dover assomigliare alla maschera di ubriacone dissennato che i media gli stanno appiccicando addosso.
È il 14 luglio del 1992. Da lì principia la serie di fotografie del volume Tom Waits di Guido Harari, da poco uscito per Tea. Il noto fotografo definisce “melodia cinetica fatta di piccoli scatti” il movimento instancabile dei muscoli facciali e delle braccia del grande musicista americano quando ha la fortuna di incontrarlo nella bellissima Place des Vosges di Parigi per la promozione dell’album Bone Machine. Un uomo la cui pelle sembra fatta di una gomma dura ed elastica insieme, in grado di fargli assumere sembianze e maschere diverse di uno stigma originario che è quello di un vero genio. Se “il viso gli si gonfia e deforma” spiazzando il fotografo, e se la sessione di scatti troverà la sua cifra soltanto nel gesto improvvisato di Waits che afferra un telo scuro pensato come fondale e trasformato in un gigantesco mantello dentro e sotto il quale svolazzare come uno strambo animale, così il giornalista Burt Bull nel novembre del ’77 (Waits comincia a farsi un nome importante) non sa bene che pesci prendere nel suo goffo tentativo di imbastire un’intervista decente col musicista seccato di dover assomigliare alla maschera di ubriacone dissennato che i media gli stanno appiccicando addosso. È solo una delle decine di interviste raccolte nel volume Il fantasma del sabato sera, (messe insieme da Paul Maher Jr, e tradotte da Minimum Fax) che coprono tutta la sua lunga carriera e costituiscono una fonte preziosissima per vedere più da vicino dentro l’officina creativa di uno straordinario e sensibilissimo performer oltre che autore, la cui grandezza per orecchie non abbastanza attente è forse adombrata dall’aspetto burlesco e camaleontico della messinscena. Harari lo rivede ai tempi di Mule Variatons in una “location anonima”. Waits gli chiede di “togliergli vent’anni”.
Ma sembra non crederci nemmeno lui. Tende piuttosto a fargli sapere che gli interessa un pubblico vero e non il numero dei biglietti venduti. Il libro di interviste chiarisce ulteriormente l’assunto. Per quanto successo abbia poi di fatto ottenuto - il cinema stesso ne è stato sedotto, come molti sanno - Waits ha sempre fatto quello che voleva, anche lasciando a bocca asciutta chi avrebbe preferito il ripetersi di certe atmosfere malinconiche e struggenti in luogo della svolta rumorista che spiazzò non poco (né pochi). Stando dalla “parte sbagliata” – quella che più giusta non si può, va da sé. L’influenza letteraria soprattutto agli inizi porta il segno di Kerouac, Bukowski e compagnie limitrofe; ma Waits per fortuna ha sempre tenuto a bada la faciloneria in odor di santità di chi pateticamente si dà del poeta. "Poesia è una parola molto pericolosa – ci avverte. - Quando qualcuno mi dice che vuole leggermi una poesia, posso immaginare un numero infinito di cose che farei molto più volentieri".
La sua musica - come sa bene chi la frequenta – muta negli anni, e muta il suo approccio agli stumenti, dalle prime chitarre ritmiche (da ragazzino Waits suonava la tromba...), al piano, alle sperimentazioni anche elettroniche “sans frontières” che dipartono dallo spoken words (fu in un disco in cui era Kerouac a parlare sopra un musica di Steve Allen che ebbe l’intuizione di cosa avrebbe potuto fare). Ai vari giornalisti racconta questo e altro, la sua empatia con il mondo della notte (di paramedici, poliziotti, netturbini, prima che di spostati), affari più o meno privati, lo sforzo per surclassare l’immagine di demenziale fenomeno da baraccone cui qualcuno provò a suo tempo a inchiodarlo. E non manca di mentire, anche, e fa bene – la menzogna nel suo caso è solo la forma di un racconto (anche perché “Waits parla davvero con quella voce”). Gli intervistatori più accorti lo sanno. Se l’uomo li prende in giro ci sta; perché non è pretenzioso, Waits, non vende fumo, e consegna agli uomini e alle donne di buon gusto un patrimonio musicale meraviglioso. Che cosa volete di più?