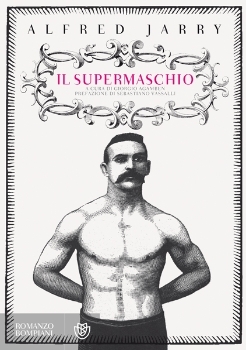“Cosa resta di tutta l’eccitazione che abbiamo creduto di provare da giovani? Niente, neppure un kleenex incartapecorito” (sì, è proprio l’incipit rivisitato di quel gran libro d’esordio di Aldo Busi che è il Seminario sulla gioventù).
La parodia, il “quasi come”, è una modalità del comico. Non la sola presente neldivertissement di Stefano SgambatiFenomenologia di youporn, “seriocomico” esercizio di lettura e analisi del godimento (della malattia?) sessuale nell’epoca della rete. Parodia che più che avvicinare gli eccessi del carnevalesco bachtiniano, utilizza un’ironia colta e ricca di richiami, ammiccamenti, sottotesti che poi si permette di sprofondare senza parere nelle piccole polle di sperma di una sega, di una polluzione, di un’eiaculatio precox di pischelli troppo adusi alla rappresentazione (del sesso femminile) per sentirsi a proprio agio con la carne vera di una donna che magari ha pure il difetto di essere mentalmente presente e volere il suo.
Una “fenomenologia”, quella di Sgambati, che all’inizio lascia un po’ perplessi visto che parrebbe corteggiare l’idea che il sesso della rete (la sua estrema fruibilità) sia stata una “rivoluzione” (lo fa ironicamente, va bene: ma non sarà un modo un po’ facile quello dell’ironia di dire e non dire? di uscirne sempre incolumi, non responsabili di fronte a ciò che sosteniamo?). Non convince il credito eccessivo concesso a una presunta “libertà” ignara del fatto che la generazione prima della sua – di Sgambati - non faticava a strappare paginette (a colori eh) dai giornali giusti, sparpagliare le foto porno per terra, dargli un po’ di movimento e andarsene con dio – credo si tratti di un’enfasi (tardo)giovanile che aspetta soltanto di fare il suo tempo.
Difatti accade quasi in diretta, sotto gli occhi del lettore, se, attraversato il centro nevralgico del libretto (un’“analisi filologica e post-strutturalista del video pornoamatoriale di Belén Rodriguez”), Sgambati pensa bene di doversi rivolgere a uno psicoterapeuta, preoccupato che la sua (la nostra) sia ormai una condizione insana: una dipendenza, non so quanto diversa dalla più generale rinuncia a una vita “vera”, in favore del mondo “altro” della rete.
Più che all’Eco della paradigmatica analisi di Mike Buongiorno, riferimento che di tutta prima parrebbe obbligato, Sgambati pare guardare ai Diari minimi (e l’eco di comici migliori di Eco risuonano diffusi nel testo). Perché più che il valore veritativo di una fenomenologia che si voglia “seria” – una fenomenologia radicata su un terreno filosofico - Sgambati enfatizza comicamente l’emozione della visione (la fica dell’argentina spalancata davanti ai suoi occhi) utilizzando insieme le figure dell’iperbole e dell’enumerazione; se la prima reazione è l’erezione e la seconda l’euforia, poi il narratore spicca un volo che lo allontana dall’oggetto e lo lancia sul palcoscenico di una performance attoriale: “mi sono messo a pensare a Gesù Cristo, ecco, alla giustizia divina, a Togliatti, Pasolini, Omero, alla strage di Bologna, agli amici morti, agli amori che mi hanno distrutto la vita, ai fallimenti, alle ingiustizie. Mi sono messo a pensare alle cose enormi e a quelle infinitesimali, mi sono messo a pensare perfino all’Africa, all’affitto, al Terzo Mondo, a quei poveri bambini con i ventri gonfi come le pance delle asine gravide” etc (non è finito).
Il che, se aumenta il divertimento di qualche lettore, rende meno stringente l’indagine sul “fenomeno” porno in rete (peraltro, il clamore per il video di una donna che potrebbe anche essere la più desiderata del mondo non tiene conto che quel video è la cosa meno eccitante di tutta la storia del porno). Nel che non v’è alcun male, va da sé. Lo diciamo per chiarire meglio al lettore che tipo di testo abbiamo davanti; ma anche per segnalare quello che è un po’ il limite di un autore non privo di talento: il desiderio di far ridere a tutti i costi. Con due conseguenze, a mio avviso. La prima è che se Sgambati è capace di una scrittura brillante, crepitante, arguta, l’ansia di far ridere, di portare palla e dribblare anche le bandierine, gliela fa perdere banalmente. Per un sommario regesto: l’aggettivo “kafkiane” lo si vorrebbe abolito dalla comunicazione colta; oppure le facce trasformate in “raccapriccianti urli di Munch”, o ancora “l’esistenza di dio” provata dal video di Belen: suonano un po’ troppo da liceale che “sa” ma dimentica che “sanno”, già, anche gli altri.
Vero è che la scrittura da performer di molte di queste pagine ben si adatta all’andazzo di questi ultimi anni in cui molti scrittori passano più tempo a leggere per locali che a scrivere. Succede soprattutto nella piccola editoria, che tenta di sopperire alla scarsezza di mezzi e agli ovvi problemi di visibilità. La scrittura si mette in scena, lo scrittore si fa attore, non sempre a proposito (il più delle volte le letture pubbliche sono noiose assai). Ecco, la “fenomenologia” di Sgambati invece la vedrei bene recitata su un palcoscenico – ma è solo un mio parere. L’altra conseguenza del voler far ridere a tutti i costi, è che l’autore afferra dove può. Sgambati conosce le migliori battute di Woody Allen a memoria e diverse ne usa qua sopra, un po’ mascherandole nel testo. Ora, sulle Postille al Nome della rosa, per tornare a Eco, Sgambati avrebbe potuto leggere che “i debiti si pagano”. Nella pagina finale su “fonti e ispirazioni” (che sono anche un modo per ringraziare chi ci ha insegnato il mestiere) il nome di W.A. brilla per la sua assenza.
Il libro (una fantasiosa confezione delle Miraggi Edizioni), non si esaurisce qui. Contiene infatti quattro brevissimi contributi di Enrico Remmert, Gaja Cenciarelli, Roberto Moroni e dell’assai briosa Carolina Cutolo: dai quali emerge un senso di disillusione rispetto al paradiso promesso del porno in rete. Com’è giusto. Perché, se il porno è tutto qui e ora, l’uso massiccio che ne consente la rete finisce per decretare non la fine della Storia, ma delle piccole grandi storie con cui tessiamo la tela delle nostre vite – lo faceva notare anche un articolo di qualche settimana fa di Marco Mancassola. Chissà se Nietzsche ne sarebbe stato contento.